Salvatore Garbellano, Docente a contratto di Management and Organizational Behaviour al Politecnico di Torino

Di quali caratteristiche dovranno dotarsi gli imprenditori e i manager in futuro? “Se i primi dovranno essere trasformazionali, i secondi non potranno che essere di movimento”.
La previsione è di Salvatore Garbellano, Docente a contratto di Management and Organizational Behaviour al Politecnico di Torino, contenuta nel suo libro, pubblicato da FrancoAngeli e dedicato alle qualità che dovranno avere le guide aziendali dei prossimi anni, sempre più contrassegnati da cambiamenti veloci e grande incertezza.
Professore, al di là degli aggettivi altisonanti, a quali figure ci riferiamo?
Imprenditori trasformazionali e manager di movimento sono espressioni chiave per comprendere i fattori che hanno consentito alle imprese di crescere anche nei periodi di maggiore incertezza. Gli imprenditori trasformazionali hanno due punti di partenza in comune: riescono a vedere quanto per gli altri è nascosto e implementano processi di trasformazione. Trasformare le imprese è più ambizioso che cambiarle. Non è soltanto aumentare il fatturato o il numero dei dipendenti. Trasformare vuol dire che ogni decisione rilevante fa crescere il potenziale di crescita dell’impresa rendendola più solida e competitiva.
Esempi?
Imprenditore trasformazionale è stato Michele Ferrero che, da una crema di nocciole, ha costruito una grande azienda multinazionale, così come, ad esempio, gli imprenditori di Carel che, sin dalla fondazione dell’azienda, hanno investito nello sviluppo tecnologico (dai sensori, ai robot collaborativi all’intelligenza artificiale) per soddisfare e anticipare i bisogni dei clienti.In primo luogo, si tratta di imprenditori che hanno il controllo del proprio prodotto, per riprendere una frase di Nicola Michelon, Amministratore Delegato di Unox. Hanno dato centralità alla produzione. Da un lato, verticalizzano le attività – grazie all’utilizzo delle tecnologie di Industria 4.0 e oggi anche di intelligenza artificiale che consentono rapidità, flessibilità e efficienza, richieste oggi dai clienti – e avviano strategie di servitizzazione. Dall’altra, aggregano imprese in possesso di know how rilevante per il business e ridisegnano le catene di fornitura secondo il criterio della prossimità territoriale. Gli imprenditori trasformazionali si aprono al management, alle collaborazioni con le università, al mondo finanziario e al territorio: sono consapevoli della necessità di superare i propri limiti e quindi di collaborare con chi possiede o crea la nuova conoscenza (fornitori di tecnologie, centri di ricerca, startup e spin off).
In questi contesti chi sono e cosa fanno i manager di movimento?
I manager di movimento sono i nuovi manager dell’innovazione. Pur avendo ruoli diversi nelle aziende – dal Chief Technology Officer in Nice Spa, Chief Technologies and Infrastructures Officer in Ferrari, Digital Innovation Manager in Breton SpA– hanno la responsabilità di intercettare le traiettorie tecnologiche, selezionare le tecnologie emergenti e implementarle nei processi, prodotti e servizi delle imprese. Per questo motivo devono operare anche negli ecosistemi dell’innovazione per rinnovare il know how delle imprese e spesso creare customer experience coerenti con le attese e i bisogni dei clienti.
Quanto oggi siamo lontani, almeno in Italia, da guide aziendali trasformazionali?
Ho sviluppato il modello delle aziende trasformazionali prendendo in considerazione le imprese leader innovative che si concentrano tra Emilia-Romagna (ad esempio, Marchesini, Ima, E80Group), Lombardia (quali, Brembo e Idra Group) e Veneto, benché siano presenti in altre regioni. Ad esempio, Pattern e Acqua Sant’Anna in Piemonte, Loccioni e Angelini nelle Marche, Mermec e Masmec in Puglia. Il modello ha le sue radici nei grandi imprenditori italiani: Adriano Olivetti, Michele Ferrero e Aristide Merloni, tutti imprenditori visionari, capaci di costruire aziende innovative, aperte al territorio e attente alle persone. All’estero un punto di riferimento è costituito dalle medie imprese bavaresi che collaborano con i Fraunhofer, gli istituti specializzati nella ricerca applicata.
Come ci si dovrebbe preparare?
Guidare le aziende trasformazionali richiede una rifocalizzazione delle priorità della formazione. Occorre preparare manager che sappiano creare connessioni tra saperi diversi, tra processi gestionali e operativi e tra mondi e organizzazioni che hanno finalità e linguaggi diverse, ma possono essere complementari. Ad esempio, uno degli obiettivi della Academy di Cereal Docks è creare interazioni stabili con università, clienti e territorio. Creare reti di innovazione e apprendimento è anche responsabilità delle istituzioni per far crescere e rendere attrattivi i territori.
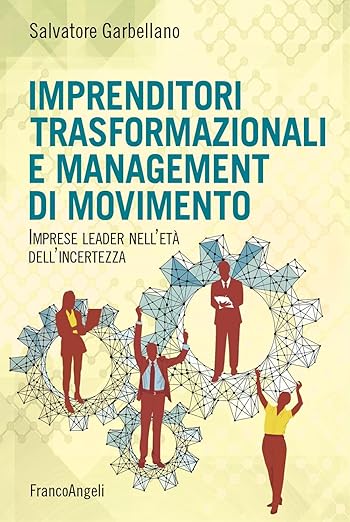
Cosa succede se i leader rimangono fermi a compiacersi dei propri risultati?
Fare impresa richiede azione e riflessione, ma oggi la riflessione deve tendere al miglioramento continuo, a rendere le imprese preparate al cambiamento e spesso ad anticiparlo. Per chi sta fermo accade quanto spesso avviene nelle corse. Il distacco tra i migliori e quelli che aspettano diventa sempre più ampio e in molti casi impossibile da colmare.
Altre aziende che con imprenditori trasformazionali e manager di movimento sono già a buon punto?
Oltre alle aziende già citate, vorrei ricordarne due. Sono manager trasformazionali che hanno un forte spirito imprenditoriale. Il primo Andrea Pontremoli che ha fatto leva sul know-how di Dallara Automobili per diversificare l’azienda nei servizi tecnologici ad alto valore aggiunto. Il secondo è Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, che ha investito nella nuova fabbrica di Maranello in grado di connettere nuove tecnologie, artigianalità e garantire ai clienti la scelta del tipo di motore (elettrico, ibrido o meccanico), conservando le stesse emozioni della guida. Entrambi capaci di cogliere le intersezioni tra tecnologie e nuove attese dei clienti creando valore condiviso per l’azienda, dipendenti e territorio.
In una fase di cambiamenti continui quale deve essere la nuova bussola per imprenditori e manager?
La capacità di esser padroni del proprio prodotto nel prossimo futuro. Vuol dire crescere e creare connessioni con chi crea conoscenza. Per manager e imprenditori occorre saper individuare le nuove possibili integrazioni tra tecnologie emergenti e i bisogni emergenti dei clienti e continuare a investire sia nelle persone sia nello sviluppo tecnologico.
Qual è l’aspetto che oggi fa più paura a imprenditori e manager?
La rottura degli equilibri politici ed economici che si sono consolidati negli ultimi decenni crea non soltanto incertezza, ma anche timori di eventi sino a poco tempo fa imprevedibili. È un’incertezza che riguarda tutti: clienti, imprese, istituzioni.
In futuro come un’azienda riuscirà a lasciare il segno?
Le aziende e i suoi leader lasciano il segno quando hanno impatto positivo sulla vita dei dipendenti, sull’attrattività dei territori e il benessere delle comunità. I principali azionisti della Dallara hanno creato un trust che vincola le prossime generazioni a mantenere le aziende sul territorio, premiare chi vi lavora con passione e dare una continua attenzione alla ricerca e allo sviluppo. Una buona prassi da seguire.
Cinzia Ficco
![]()